|
Cos'è?
L'ecocardiogramma è l'esame
del cuore basato sull'impiego degli ultrasuoni (suoni con frequenze
elevatissime, non udibili dall'orecchio umano). Permette la visualizzazione
dell'anatomia cardiaca e di studiare il cuore in azione.
Come funziona?
Un fascio di ultrasuoni
viene emesso da una sonda penetra nei tessuti del torace raggiunge le strutture
cardiache. Sfruttando le leggi fisiche della riflessione e rifrazione gli
ultrasuoni di ritorno dai tessuti vengono captate dalla stessa sonda e
rielaborati in modo da fornire immagini dalle quali si possono trarre utilissime
indicazioni sull'anatomia, sul funzionamento e sullo stato di salute del cuore
in esame.
A cosa serve?
Consente di esaminare la
morfologia delle strutture cardiache (pareti, valvole, cavità) e di studiare il
funzionamento del cuore in movimento (contrattilità, flussi, portata). Permette
quindi di vedere l'interno del cuore e di valutare come funzionano le valvole e
rilevare eventuali anomalie.
Quando si esegue?
Le indicazioni per eseguire
un ecocardiogramma si stanno estendendo notevolmente poiché fornisce
informazioni preziose sia sulle strutture che sulla funzioni del cuore. Gran
parte delle patologie cardiache trovano indicazione all'ecocardiografia, in
particolar modo le malattie valvolari e parietali del cuore, la cardiopatia
ischemica.
Si esegue quando serve una:
-
valutazione qualitativa e
quantitativa delle malattie delle valvole cardiache,
-
valutazione del movimento
delle pareti cardiache e sue anomalie,
-
valutazione delle
cardiopatie congenite,
-
valutazione del danno
miocardico in malattie ed elevato interesse sociale ed a notevole incidenza
della popolazione: ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, diabete,
ecc...,
-
valutazione degli esiti di
un intervento operatorio correttivo nelle cardiopatie congenite o acquisite,
-
valutazione delle protesi
valvolari- misurazione semiquantitativa di gradienti e flussi in presenza di
valvole stenotiche o insufficienti.
-
diagnosi di tutte le
malattie cardiache in gravidanza con possibilità anche di diagnosi intrauterina
di gravi cardiopatie congenite fetali.
Con l'esame
ecocardiografico si può
1. valutare la
funzione ventricolare calcolando le dimensioni delle varie strutture, volume e massa
del ventricolo sinistro, funzione sistolica globale (con il calcolo della
frazione di eiezione), funzione sistolica dei vari segmenti della parete dei
ventricoli; con il doppler è possibile ottenere anche notizie sullo stato emodinamico del cuore, sia nella fase sistolica che diastolica;
2. ottenere
valutazioni emodinamiche (informazioni che prima dell'ecocardiografia
erano fornite solo dallo studio invasivo con cateterismo cardiaco): volume
di gittata e portata cardiaca, gradienti di pressione, areee
valvorari, pressioni intracardiache, funzione sistolica e
diastolica;
3. valutare le
funzioni valvolari quantificando le alterazioni (stenosi, insufficienze)
delle valvole cardiache e delle protesi valvolari, le pressioni all'interno di
alcune strutture (arteria polmonare), la gittata cardiaca, l'entità dello shunt
nelle comunicazioni patologiche tra strutture cardiache;
4. valutare la
situazione del miocardio in corso di malattia coronarica mediante l'esame della
motilità (cinesi), dello spessore e della qualità parietale. In questo campo,
l'ecocardiografia gioca un ruolo importante nella diagnostica delle
coronaropatia, nel riconoscimento e trattamento precoce dell'infarto del
miocardio e delle sue complicanze, nella stratificazione prognostica dei
pazienti postinfartuati, nel follow-up di pazienti sottoposti a procedure di
rivascolarizzazione cardiaca chirurgica o con angioplastica.
Prima dell'avvento
dell'ecografia, alcuni campi della patologia cardiaca erano difficilmente
esplorabili mentre attualmente, in pochi minuti, è
possibile fare diagnosi precise e intraprendere le terapie più adatte.
L'ecocardiogramma infatti è un esame utile sia per una
prima diagnosi di cardiopatia sia per controllare l'evoluzione delle
alterazioni cardiache nel tempo. Per esempio nella cardiopatia ischemica l'esame
ecocardiografico permette di fare diagnosi di ischemia o infarto attraverso il
riscontro di alterazioni, rispettivamente transitorie o stabili, di definirne la
sede e l'estensione e di seguirne l'evoluzione nel tempo.
È utilissimo nelle diagnosi
delle malattie di cuore congenite sia del bambino che dell'adulto.
Con l'esame ecocardiografico
si possono ottenere indicazioni decisive circa i tempi e le modalità per gli
interventi chirurgici sulle valvole cardiache.
Come si esegue?
Il cardiologo esamina il cuore del paziente,
disteso sul fianco sinistro, mediante una sonda che gli appoggia sul
torace (approccio transtoracico). L'operatore vede le immagini in tempo reale,
valuta la situazione cardiaca e può registrare o stampare le immagini più
significative. Anche il paziente può vede il suo cuore "in diretta" nel monitor.
I vantaggi
dell'ecocardiografia sono molteplici:
-
è innocuo, non utilizza
emissioni di raggi X o sostanze radioattive,
-
è indolore,
-
dura circa 30 minuti,
-
è ripetibile,
-
l'attrezzatura utilizzata
per l'esame è mobile, facilmente trasportabile,
-
fornisce informazioni
dell'anatomia e della funzionalità del cuore,
-
può essere utilizzato come
screening
È
ripetibile ed innocuo anche quando viene eseguito in gravidanza.
In quale misura questo
esame dipende dall’esperienza e dalla capacità dell’operatore?
Molto. È un esame che richiede competenza
per posizionare correttamente la sonda, per dirigere precisamente il fascio
ultrasonoro esploratore, per produrre immagini chiare e corrispondenti alla
realtà, per eseguire riproduzioni oggettive e produrre interpretazioni
riflettute, sufficientemente fondate e chiaramente provate.
Che differenza c'è fra un tipo e l'altro di ecocardiogramma?
La qualità dell'immagine ottenuta sul monitor dipende dalla
possibilità di
penetrazione degli ultrasuoni all'interno del torace. Con gli ecografi moderni
si possono eseguire ecocardiogrammi secondo quattro modalità:
-
Monodimensionale (Ecocardiografia
M-mode),
-
Bidimensionale (Ecocardiografia
B-mode)
-
Doppler (Ecocardiografia
Doppler)
-
Doppler con codifica di
colore (Ecocardiografia
Color-Doppler)
-
Le prime due forniscono informazioni su
dimensioni delle camere cardiache, spessore delle pareti, contrattilità
miocardica, anomalie dei vasi venosi ed arteriosi e struttura delle valvole;
-
le ultime due, grazie alla tecnica doppler applicata
durante l'esame ecocardiografico permettono di valutare il flusso di sangue
(direzione e velocità) nelle cavità cardiache e attraverso le valvole e di quantificare
le disfunzioni valvolari (stenosi e/o insufficienza).
a)
Modalità M:
un cristallo trasmettitore-ricevitore
genera impulsi di breve durata ad elevata frequenza, e la misurazione del tempo
necessario
perché il segnale venga riflesso consente
di calcolare la distanza dai vari confini con tessuti aventi diverse densità
acustiche attraversati dall'ultrasuono. Con l'uso di un sottile fascio di
ultrasuoni si ottiene una sezione monodimensionale del cuore che permette di
effettuare misurazioni e valutazioni dettagliate delle strutture cardiache. La
figura seguente ne è una rappresentazione.
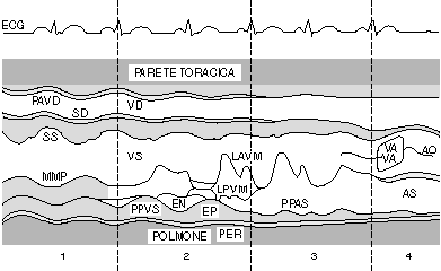 Rappresentazione
schematica dell'ecocardiografia M-mode del cuore, dall'apice (1) alla base (4)
del cuore. Rappresentazione
schematica dell'ecocardiografia M-mode del cuore, dall'apice (1) alla base (4)
del cuore.
PAVD = parete anteriore del ventricolo
destro;
VD = cavità del ventricolo destro; SD = versante destro del setto
interventricolare; SS = versante sinistro del setto interventricolare; VS =
cavità ventricolare sinistra; MPP = muscolo papillare posteriore; PPVS = parete
posteriore del ventricolo sinistro; EN = endocardio posteriore del ventricolo
sinistro; EP = epicardio posteriore del ventricolo sinistro; PER = pericardio;
LAVM = lembo anteriore della valvola mitrale; LPVM = lembo posteriore della
valvola mitrale; PPAS = parete posteriore dell'atrio sinistro; VA = valvola
aortica; Ao = aorta; AS =
cavità dell'atrio sinistro.
(Da Feigenbaum H: "Clinical
applications of echocardiography." Progress in Cardiovascular Diseases
14:531-558, 1972).
b)
Ecografia bidimensionale:
mediante l'emissione di raggi ultrasonori in varie direzioni questa metodica
fornisce un'immagine del cuore a due dimensioni e in tempo
reale. L'uso congiunto di queste tecniche fornisce utili informazioni per
diagnosticare stenosi mitralica o aortica, dilatazione del ventricolo
sinistro o destro, ipertrofia ventricolare sinistra, endocardite
infettiva, mixoma atriale, cardiopatie congenite, versamento
pericardico e tamponamento cardiaco.
c)
Ecodoppler: il cambiamento di frequenza
negli ultrasuoni di ritorno fornisce informazioni su velocità e direzione del
flusso sanguigno nel cuore. Il Doppler può essere pulsato o a onda continua: quest'ultima variante consente la registrazione di velocità elevate ed è
particolarmente utile per individuare le stenosi valvolari.

d)
Ecodoppler a colori: sovrappone
molteplici segnali Doppler
ad un'immagine bidimensionale, evidenziando il flusso
sanguigno con una codifica a colori: il sangue che fluisce verso il trasduttore
è riportato in rosso, e quello che se ne allontana in blu; le alte velocità
appaiono come "piume" bianche o verdi. Consente di meglio individuare
rigurgiti mitralici o aortici, difetti del setto interventricolare o
altre anomalie congenite, difetti delle protesi valvolari. L'ecocardiografia
color-doppler particolarmente idonea allo studio dei flussi di sangue nelle
cavità cardiache e attraverso le valvole.
Ci sono altre applicazioni
dell'ecocardiografia?
1. Per approfondimenti
ulteriori, soprattutto nello studio delle aree ischemiche o infartuate della
muscolatura cardiaca si associa l'ecocardiogramma a sforzo fisico (ecocardiogramma
da sforzo) o all'infusione di farmaci particolari come
dipiridamolo o dobutamina che producono uno stress cardiaco guidato e
monitorizzabile (ecostress)
e così evidenziare patologie non presenti in condizioni basali, ma solamente
durante situazioni di impegno cardiaco, permettendo di valutare meglio la funzionalità
delle arterie coronariche.
2. Quando l'esame ecocardiografico eseguito
all'esterno del torace (approccio transtoracico) non offre immagini
soddisfacenti o risultati definitivi si può eseguire l'ecocardiogramma con
una piccola sonda montata su un gastroscopio introdotta nell'esofago (ecocardiogramma
transesofageo). Questa tecnica permette di
visualizzare l'auricola sinistra e l'aorta toracica che sono scarsamente
valutabili con l'esplorazione tanstoracica. Inoltre in soggetti obesi, con
deformità toraciche, con traumi recenti permette di ottenere immagini di
qualità non altrimenti possibili. È
particolarmente utile quando c'è il sospetto di masse atriali, difetti settali, dissecazione aortica; serve per esaminare con maggior dettaglio la valvola mitrale, per individuare le
complicanze dell'endocardite infettiva, per il monitoraggio
intraoperatorio della chirurgia cardiaca, per escludere con certezza la
presenza di trombi intracardiaci (soprattutto in vista di una procedura di
cardioversione).
3.
Utilizzando particolari sostanze che vengono introdotte nel sangue mediante
iniezioni endovenose producono contrasti di immagine (ecocontrastografia)
che permettono di ottenere informazioni sul flusso sanguigno nel cuore (e così
svelare la presenza di flussi anomali per la presenza di difetti
congeniti) e nelle coronarie per lo studio della vascolarizzazione del cuore e
della malattia coronarica. È una tecnica ancora per molti versi in fase
sperimentale.
4.
L'effettuazione di ecocardiogramma al feto (ecografia
fetale) permette di
individuare eventuali malformazioni fin dalle prime settimane della sua vita,
consentendo diagnosi precocissime e rendendo possibili i provvedimenti
terapeutici tempestivi subito dopo la nascita.
5. La
metodica eco-color-doppler si applica per lo studio vascolare di vari distretti
cicolatori. In particolare va ricordato il
ECOCOLOR-DOPPLER DEI VASI EPIAORTICI o
ECOCOLORDOPPLER dei tronchi sopraortici (T.S.A.)
È lo studio ecocolordoppler dei vasi che
nascono dall'aorta (per questo si chiamano vasi epiaortici) rappresentati da due
coppie di arterie: le carotidi e le vertebrali. Sono vasi 'strategici' perché
portano il sangue al cervello (tronchi sopraortici), per cui un loro
restringimento (come nell'aterosclerosi) può comportare un deficit cerebrale.
Con tale esame si possono evidenziare le alterazioni di parete (ispessimenti,
depositi atersoclerotici) o la presenza di placche fibrocalcifiche endoluminali
in grado di determinare, o meno, fenomeno di stenosi e/o occlusioni con
manifestazioni cliniche più o meno gravi che vanno dall'attacco ischemico
transitorio (T.I.A.) al vero e proprio ictus cerebrale. La localizzazione
preferenziale delle placche è al livello della biforcazione carotidea perché in
tale sede si verificano delle condizioni emodinamiche favorevoli al formarsi di
tali lesioni. L’ecocolordoppler dei T.S.A. è indicato sia per lo studio di tutte
le malattie correlate a disturbi della funzionalità del Sistema Nervoso Centrale
(sindromi vertiginose, disturbi della motilità, del linguaggio ecc...), sia per
la prevenzione di tali patologie in soggetti a rischio (diabetici, ipertesi,
forti fumatori, dislipidemici)
|

